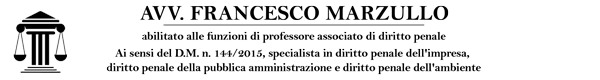A distanza di circa due anni da un precedente lavoro sul tema dell'interruzione della prescrizione dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001(pubblicato nel 2018 sulla Rivista online "Nel diritto"), l'avv. Marzullo è tornato sul medesimo argomento, dando conto dei più recenti arresti giurisprudenziali (da ultimo, la sentenza n. 1432 del 15 gennaio 2020) che propendono per la tesi meno garantista per le persone giuridiche e società in genere (attinte in sede penale da un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/01) ossia per quella tesi che attribuisce natura "non ricettizia" all'atto di imputazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 del d.lgs. in parola.
Il tema è sempre più attuale e ricorrente anche in ragione del costante aggiornamento -ad opera del nostro legislatore- del catalogo dei reati presupposto (cfr. reati tributari).
Tale lavoro è stato pubblicato anche sul sito online dell'Associazione Etica231
Le modalità di interruzione (mediante atto imputativo) della prescrizione della sanzione amministrativa ex d.lgs. 231/01.
Due orientamenti giurisprudenziali a confronto.
di avv. Francesco Marzullo,
docente di diritto penale presso Scuola di Specializzazione delle professioni legali, Università di Bari
Sommario:
5. Rebus sic stantibus, diamo la parola alla Consulta o alle SS.UU.
Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 231/01, il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo è di 5 anni dalla data di consumazione del reato presupposto, termine che può essere interrotto esclusivamente dalla richiesta di applicazione di misura cautelare interdittiva e dalla contestazione dell’illecito amministrativo mediante richiesta di rinvio a giudizio (art. 22 comma 2 d.lgs. 231/01).
Il tema è di grande attualità per i suoi rivolti eminentemente pratici posto che non è infrequente il caso in cui il P.M. adotti l’atto di contestazione dell’illecito amministrativo nei confronti della persona giuridica prima che siano decorsi 5 anni dalla consumazione del reato presupposto; e che tuttavia tale atto imputativo sia notificato all’ente dopo che i predetti 5 anni siano decorsi.
In un ipotesi siffatta, il Giudice è tenuto a dichiarare la prescrizione dell’illecito amministrativo oppure può ritenere comunque tempestiva la contestazione rivolta all’Ente ex art. 59 del d.lgs. 231/2001 con la inevitabile conseguenza che la prescrizione resterà sospesa per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza definitiva.
Prima di fornire una possibile risposta a tale quesito, per completezza è bene soffermarsi su un confronto tra la disciplina dell’interruzione della prescrizione del reato (a carico della persona fisica) e la disciplina dell’interruzione della prescrizione dell’illecito amministrativo (a carico dell’Ente).
Entrambe le discipline presentano analogie e differenze.
I termini di prescrizione dell’illecito amministrativo sono più ridotti, appena 5 anni e non dipendono in alcun modo dalla gravità del reato presupposto (ascritto agli apicali o ai sub apicali) che fa scaturire la responsabilità dell’Ente. Si tratta di un termine inferiore di 1 anno rispetto al termine minimo previsto per la prescrizione dei delitti dall’art. 157 c.p. (salvo un termine più lungo che coincide con il massimo della pena edittale prevista da ciascuna fattispecie incriminatrice).
Per quanto attiene alla tipologia degli atti interruttivi, il novero degli eventi interruttivi della prescrizione dell’illecito amministrativo è più ristretto rispetto agli atti tipizzati in relazione alla prescrizione del reato e previsti nell’art. 160 c.p.
L’art. 22, comma 2, del d.lgs. 231/01 prevede due atti interruttivi dell’interruzione della prescrizione dell’illecito amministrativo.
Il primo è la richiesta (avanzata dalla Procura) di applicazione di misura cautelare interdittiva; il secondo atto è la contestazione dell’illecito amministrativo ex art. 59 del d.lgs. 231/01 (norma che a sua volta rinvia ad uno degli atti tipici di esercizio dell’azione penale nei confronti della persona fisica ai sensi dell’art. 405 comma 1 c.p.p.).
Gli effetti prodotti dai predetti atti interruttivi sia con riferimento all’illecito amministrativo sia con riferimento al reato sono gli stessi, ossia la decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione (art. 22 comma 3 d.lgs. 231/01 e art. 160 comma 3 c.p.).
La vera differenza riposa nel fatto che, rispetto al reato, in presenza di plurimi atti interruttivi, i termini di prescrizione non possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161 comma 2 c.p.; viceversa, rispetto all’illecito amministrativo, nel caso di interruzione della prescrizione mediante atto imputativo, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 22 comma 4 del d.lgs. 231/01).
In buona sostanza, la contestazione dell’illecito amministrativo costituisce una sorta di interruzione “sine die” della prescrizione che non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Per dirla in breve, le sorti di un Ente (con le relative ricadute economiche e sociali) finiscono per dipendere da un processo (teso ad accertare la sua responsabilità amministrativa) che può durare decenni.
Pertanto, posto che l’atto di contestazione dell’illecito amministrativo è foriero di tali significative conseguenze negative per l’Ente, è opportuno tornare al nostro interrogativo di partenza, ossia l’atto imputativo a carico della persona giuridica, per essere ritenuto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, oltre che “emesso” deve anche essere “notificato” entro 5 anni dalla consumazione del reato presupposto ovvero entro 5 anni dal precedente atto interruttivo (la richiesta di misura cautelare interdittiva).
Nell’attuale panorama giurisprudenziale si registra un primo orientamento di legittimità e di merito, improntato ad un maggior garantismo, secondo cui, quando l’atto interruttivo coincide con l’atto imputativo dell’illecito amministrativo (art. 59 del d.lgs. 231/2001), al fine di interrompere la prescrizione in materia di illeciti amministrativi ex d.lgs. 231/01, si deve aver riguardo non alla data di emissione dell’atto interruttivo, ma alla sua notifica.
Entrando più nel dettaglio, si segnalano le seguenti sentenze della Suprema Corte che aderiscono a questo primo orientamento, senza dubbio ispirato a maggiore garantismo.
- a) Nella sentenza Bonomelli (10.11.2015 n. 28299), la Sez. VI della Cassazione penale ha statuito che l’art. 22 d.lgs. 231/2001 ha puntualmente attuato i principi di delega contenuti nella legge 29 settembre 2000 n. 300 che, all’art. 11, lett. r) prevedeva espressamente che l’interruzione della prescrizione dovesse essere regolata dalle norme del codice civile, disposizione che replicava, con altrettanta puntualità, il contenuto dell’art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689, che proprio in materia di illecito amministrativo richiama la disciplina della prescrizione del codice civile. E’ evidente che in questa materia il legislatore ha attuato una differenziazione del regime di prescrizione avendo ben presente le ragioni consistenti nella diversità tra illecito amministrativo, fondante la responsabilità delle persone giuridiche, e reato e, conseguentemente ha adeguato la disciplina della prescrizione riferita all’ente al regime già previsto dalla legge generale sulla depenalizzazione del 1981 per l’illecito amministrativo punitivo.
Deve poi escludersi che la disciplina prevista dall’art. 22 citato sia in conflitto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 11 comma 2 Cost.), anche inteso come diritto ad essere giudicati senza ritardo. Tant’è vero che il d.lgs. 231/01 ha, da un canto, introdotto un termine di prescrizione oggettivamente breve, pari a soli 5 anni dalla consumazione dell’illecito, nella dichiarata intenzione di contenere la durata della prescrizione e di non lasciare uno spazio temporale eccessivo ampio per l’accertamento dell’illecito nel corso delle indagini, anche per favorire le esigenze di certezze di cui necessità l’attività d’impresa, da altro canto, ha previsto un regime degli effetti interruttivi che replica la disciplina civilistica, stabilendo che una volta contestato l’illecito amministrativo, <<la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>>.
Così facendo, il legislatore ha realizzato un bilanciamento tra le esigenze di durata ragionevole del processo, soprattutto nel prevedere un termine breve di prescrizione e le esigenze di garanzia che devono consistere nel valore della completezza dell’accertamento giurisdizionale riferito ad una fattispecie complessa come quella relativa all’illecito amministrativo dell’ente.
E’ sufficientemente chiaro che la “ratio” di tale bilanciamento risiede nella tendenziale riduzione del termine di prescrizione una volta che, esercitata l’azione penale, si incardini il giudizio, con il contrappeso rappresentato dalla ridotta durata del termine di prescrizione, fissato per tutti gli illeciti in 5 anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quello previsto dal codice penale.
Per concludere sul punto, a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo nelle forme di cui all’art. 59 d.lgs. 231/2001, a differenza di quanto accade per i reati, si vanifica il rischio che nel corso del processo (fino a sentenza definitiva) si debba dichiarare l’estinzione dell’illecito amministrativo per il sopraggiungere della prescrizione, come speso accade per il reato presupposto.
- b) Nella sentenza Buonamico (12.2.2015 n. 18257) la Sez VI della Cassazione penale prende le mosse dalla lettera r) dell’art. 11 della legge n. 300/2000 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) secondo cui “l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ad avviso della Suprema Corte: “nella disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 c.c.) l’effetto di interruzione si ottiene con la portata a conoscenza dell’atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali”.. In linea con tale pronuncia, si pone altra sentenza della Suprema Corte n. 20060 del 4.4.2013 in cui si statuisce che in materia di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01 si devono applicare le norme di cui agli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c.; di qui la necessità che il “processo venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato”.
- c) A ben vedere il ragionamento seguito dalle due sentenze del 2015 Buonamico e Bonomelli è stato in parte anticipato già svolto nella nota sentenza Citybank (4.4.2013 n. 20060) della Quinta Sezione della Cassazione. In particolare nel 2013 la Suprema Corte statuisce che se è vero che l’illecito amministrativo si prescrive in 5 anni dalla commissione del reato, è anche vero che si devono applicare le cause interrutive del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento. Sicchè, a norma degli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c., la prescrizione è interrotta dall’atto con il quale si inizia il giudizio. Ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio (allorchè la connessione con i reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un’infrazione amministrativa), il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato (ai sensi degli artt. 14 e 24 comma 2 della legge n. 689 del 1981) comporta l’interruzione della prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
- d) Da ultimo si segnala la più recente sentenza Tennacola s.p.a. (2.7.2018 n. 29617) con cui la Terza sezione penale della Cassazione ribadisce che il regime derogatorio della prescrizione della sanzione amministrativa ha una sua ragionevolezza in considerazione della diversa natura dell’illecito che determina la responsabilità dell’Ente, e l’impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità ex delicto di cui al d.lgs. 231/01 nell’ambito e nella categoria dell’illecito penale. Nel caso esaminato, la Terza Sezione dà atto che l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto mediante la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Abbiamo anticipato che esiste, nell’attuale panorama giurisprudenziale, un secondo orientamento (che si va consolidando ai giorni nostri, come vedremo più avanti), diametralmente opposto al primo, in cui si ritiene che l’etto interruttivo della prescrizione sia correlabile all’adozione dell’atto imputativo.
- a) Prendiamo le mosse dalla pronuncia meno recente e cioè la sentenza Cerasino (n. 10822del 15.12.2011) in cui si afferma in modo netto che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, artt. 22 e 59, la richiesta di rinvio a giudizio, nel caso in esame intervenuta prima del quinquennio, è atto di contestazione che interrompe e sospende il decorso della prescrizione sino alla sentenza che definisce il giudizio.
- b) Vi è poi la sentenza D’Errico (n. 50102 del 2015) in cui la Sesta Sezione ha affermato che l’illecito da reato contestato all’ente non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quando, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, il titolare dell’azione punitiva abbia proceduto alla formale contestazione del suddetto illecito ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 231/01. Si legge nella sentenza D’Errico che il termine quinquennale di prescrizione è stato sospeso dalla data di proposizione della richiesta di rinvio a giudizio (tempestivamente presentata entro il quinquennio da quella di consumazione del reato presupposto, come richiesto dal primo comma del citato art. 22).
- c) A seguire, si richiama il noto caso giudiziario “La Cascina” (n. 41768 del 2017) in cui la Sesta Sezione penale della Cassazione penale ha ribadito che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59, 22 comi 2 e 4 del d.lgs. 231/2001.
- d) Sulla stessa scia della pronuncia La Cascina si pone la sentenza Cirone (del 9.2018 n. 41012) in cui la Seconda Sezione della Suprema Corte torna ad affermare che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In tale sentenza si mette in chiaro che l'art. 59 del d.lgs n. 231 del 2011 (richiamato dall'art. 22 dello stesso testo) opera un rinvio integrale all’art. 405 comma 1 c.p.p. che individua -come atto di contestazione dell'illecito- la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti, che non è prevista dalla legge. Sicchè, il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consente di “trasformare” la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo, pena il rischio di manipolare arbitrariamente l’art. 22, riconducendo l'effetto interruttivo alla notifica dell'avviso di udienza, ovvero ad un atto a cui la legge non riconosce tale effetto.
Al fine di supportare la tesi circa la natura “non ricettizia”, la sentenza Cirone valorizza l’assunto che in tema di interruzione della prescrizione del reato ciò che conta è l’atto in sé, ossia nella sua materialità, tant’è che va riconosciuta, anche agli atti processualmente nulli, la capacità di conseguire lo scopo interruttivo. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno un valore ed un’efficacia obiettiva poiché denotano la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo.
- e) Nel 2019 si assiste ad altre tre pronunce della Suprema Corte (la n. 7123 del 14.2.2019, Gino Lugli s.r.l. e la n. 30634 del 12.7.2019, Coperture edil s.r.l.) in cui rispettivamente la Quarta e la Sesta Sezione penale aderiscono alla tesi della natura non ricettizia dell’atto imputativo, motivando sul punto.
- In particolare, nella sentenza 7123 si legge testualmente che l’atto interruttivo della prescrizione partecipa della natura non recettizia degli atti giudiziari, in quanto non è necessario che l'atto sia notificato agli interessati ma è sufficiente che esso sia emesso: infatti, conformemente alla "ratio" della prescrizione è la stessa emissione dell'atto, indipendentemente dalla sua notifica, a dimostrare oggettivamente la persistenza della volontà punitiva dello Stato, giacché l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto, non già dalla sua comunicazione all'interessato: l'atto ha natura recettizia per altri fini, quali le impugnazioni e per tutti gli altri casi in cui è necessario far decorrere un termine per l'esercizio di un diritto o una facoltà.
- Analogamente, nella sentenza n. 30624, dopo aver richiamato i due opposti orientamenti, si aderisce a quello meno garantista, secondo cui l’interruzione della prescrizione, nell’ipotesi di responsabilità - derivante da reato - degli enti, è finalizzata alla tutela della pretesa punitiva dello Stato; pertanto il relativo regime non può che essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato e coincidere con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, indipendentemente dalla sua notificazione. Il pregio di tale sentenza sta nel fatto che la stessa si premura di confutare l’argomento principale addotto dai fautori dell’indirizzo più garantista (espressamente ritenuto minoritario) e cioè il richiamo contenuto nell’art. 11 lett. r) della legge delega n. 300 del 2000 alle norme del codice civile che regolano l’istituto dell’interruzione della prescrizione. Ritiene infatti la Quarta Sezione che tale richiamo al regime previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., va opportunamente inteso nel senso che una volta interrotta la prescrizione, con l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, essa non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Sicchè il rimando alle norme civili non riguarda il momento della produzione degli effetti dell’atto interruttivo, ma solo il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato con l’art. 160 c.p., l’interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato.
La scelta legislativa di far riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all’art. 160 c.p., deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell’impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell’azione imprenditoriale con l’interesse generale, come espresso dall’art. 41 Cost., il quale non può recedere di fronte al vantaggio dell’attività d’impresa. Siffatta prevalenza determina la necessità del ricorso ad una normativa -quella civilistica appunto- che renda indifferente il tempo del processo all’irrogazione della sanzione, al fine di non stravolgere priorità collettive, costituzionalmente garantite.
- f) Infine nel gennaio 2020 la Terza sezione penale della Suprema Corte, con una pronuncia meramente assertiva e ricognitiva (n. 1432 del 15 gennaio 2020, Martin s.r.l.), ha ribadito che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
5. Rebus sic stantibus, diamo la parola alla Consulta o alle SS.UU.
E’ fuor di dubbio sul tema in questione vi sia un aperto contrasto tra le Sezioni semplici della Suprema Corte, anche se va detto che l’orientamento più recente e maggioritario è quello che propende per la natura non ricettizia dell’atto imputativo.
Con le doverose cautele, chi scrive ritiene sia preferibile la tesi della natura “non ricettizia” dell’atto imputativo dell’illecito ex 231, privilegiando sia l’argomento letterale (gli artt. 59 e 22 del d.lgs. 231/2001 utilizzano il verbo “contesta” che ovviamente rimanda all’emissione di un atto, il cui contenuto deve essere portato a conoscenza del destinatario) sia l’argomento sistematico rinveniente dall’art 11, lett. r) della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 (secondo cui l’interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative ex d.lgs. 231701 deve essere regolato dalle norme del codice civile).
La tesi opposta, che propende per la piena sovrapponibilità della disciplina della prescrizione del reato e di quella della prescrizione della sanzione amministrativa ex d.lgs. 231/01, trascura però un dato interpretativo ormai acquisito in sede nomofilattica (cui aderiscono le stesse SS.UU. nella sentenza n. 38343 del 18.09.2014, TyssenKrupp), in forza del quale il sistema di responsabilità ex delicto delle persone giuridiche va qualificato come tertium genus e non può pertanto essere ricondotto integralmente nell’ambito e nelle categorie dell’illecito penale.
La responsabilità amministrativa degli Enti e quella penale delle persone fisiche sono ontologicamente distinte (fiumi di inchiostro sono stati scritti sul punto in dottrina ed in giurisprudenza); e, come ebbi a segnalare in un precedente contributo sul punto, non è consentito –in nome di un maggior rigore applicativo- creare una disciplina “ibrida” o “mista” che, pur di preservare l’istanza punitiva nei confronti degli enti collettivi, da un canto “saccheggia” dal diritto penale il principio che l’interruzione della prescrizione si perfeziona con l’adozione dell’atto imputativo e dall’altro “saccheggia” dal diritto civile il principio che, una volta interrotta la prescrizione, la stessa è “congelata” fino all’irrevocabilità della sentenza che definisce il giudizio.
A questo punto, è auspicabile (a garanzia della certezza del diritto) sottoporre la questione al vaglio delle Sezioni Unite; ovvero sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 22 d.lgs. 231/2001 in ragione del fatto che la disposizione di cui all’art. 22 della legge delegata si appalesa in violazione del criterio direttivo di cui dall’art. 11 lett. r della legge delega che introduce la responsabilità amministrativa delle società (e che recita testualmente: “l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
Avv. Francesco Marzullo
Bibliografia sull’argomento:
- “La Cassazione ritorna sul tema delle modalità interruttive della prescrizione per l’illecito amministrativo dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001: tensioni interpretative tra natura penale ed amministrativa della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e perimetro di attuazione della legge delega di Francesco paolo Modugno, in Giurisprudenza penale web, 2019, 7-8
- “La decorrenza del termine di prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente da reato dell’ente”, di Lucia Aielli, in Il Penalista.it, 9 ottobre 2019
- “In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, ciò che rileva è la data di emissione dell’atto contenente la contestazione dell’illecito amministrativo e non la data della sua notifica alla persona giuridica” di Manuel Fabozzo, www.diritto.it, 12 novembre 2019
- “L’individuazione degli atti interruttivi della prescrizione nel processo avverso gli enti collettivi” di Ciro Santoriello, Il Penalista.it, 23 settembre 2019.
- “Note minime in tema di prescrizione della responsabilità da reato degli enti collettivi” di Ciro Santoriello, in Giurisprudenza penale web, 2018,10.
- “L’interruzione della prescrizione per le persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001” di Francesco Marzullo, Nel diritto.it, 2018
- “La prescrizione degli illeciti previsti dal d.lgs. 231/2001” di Luigi Ferrajoli in www.ecnews.it del 2 settembre 2016
- “L’interruzione della prescrizione nel processo a carico dell’ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito- della contestazione dell’illecito amministrativo” di Luigi Santangelo, in Diritto penale contemporaneo, 27 aprile 2015.
- “La responsabilità dell’ente da reato prescritto” di Beltrani, in Riv. Resp. Amm. Enti, 2014, n. 2.
- “L’interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001”, di Salvatore, in Riv. Resp. Amm. Enti, 2009, n. 2.